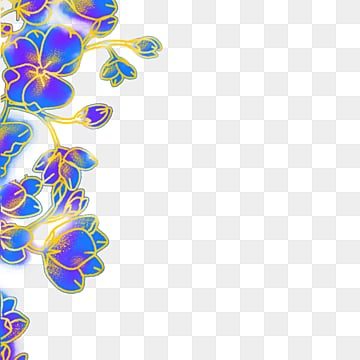“Letterale” e “letterario”, o della (scarsa) sostanza della scrittura contemporanea

Sono termini, i due qui sopra, che non di rado nel parlato quotidiano superficiale ovvero poco ragionato la gente confonde, noto. Così, ad esempio, il significato formale di qualcosa diventa “letterario” e di contro il romanzo un genere “letterale”. Nulla di male, per carità, con un poco più di attenzione e cinque secondi di lettura del dizionario l’errore può essere risolto. Tuttavia, a volte ho l’impressione che proprio la confusione più o meno diffusa di questi due termini possa rappresentare in modo assai significativo la realtà contemporanea della scrittura narrativa. Una realtà, lo dico da subito, la cui curva della qualità sul diagramma editoriale percepisco in netta e costante discesa già da tempo: vuoi perché “non li scrivono più quei grandi romanzi d’una volta!” (affermazione banale, forse, ma non poco veritiera), o vuoi perché sul mercato oggi giunge così tanta fuffa che, inesorabilmente, la media qualitativa letteraria s’abbassa – anche per colpa di editori non più consapevoli di cosa significhi veramente il termine “letteratura” – fatto sta che nelle classifiche di vendita si trovano spesso libri di valore letterario quanto meno dubbio, mentre chissà quanti ottimi lavori restano nascosti sul fondo più buio e polveroso degli scaffali delle librerie, sempre che su di essi riescano ad arrivare.
Appunto, per tornare a quella mia impressione, ho la vivida sensazione che oggi l’esercizio della scrittura – poi resa attività editoriale – sia più affine al significato del termine “letterale” che di “letterario”: scrittura che genera opere ovvie, esterne alle parole, ovvero senza alcuna profondità, senza alcuna ricerca di valore. Della mancanza contemporanea di grandi scrittori – ma forse quel “grande” è persino di troppo – ho già disquisito più volte (ad esempio qui): temo che inevitabilmente la letteratura del tempo presente finisca per essere intaccata dalla decadente e problematica realtà d’intorno, la quale non mancherebbe di offrire temi letterari importanti ma, forse, non offre di contro il contesto ideale alla loro (meditata e approfondita) narrazione, semmai imponendo necessità ed esigenze del tutto superficiali e futili che ben poco hanno a che fare con il pensiero – in senso generale, dunque artistico e letterario ma non solo – e il relativo esercizio di cognizione e comprensione del mondo d’intorno.
In tal modo la letteratura, spinta anche dal degrado di senso e sostanza dell’industria editoriale, sempre più distorta verso fini meramente imprenditoriali/industriali/finanziari e dunque consumistici al punto da rendere il libro, oggetto culturale per eccellenza, sempre più simile a qualsiasi altro bene di consumo, finisce per diventare un superficiale esercizio di scrittura, cioè di stesura di testi che si adattino il più possibile al suddetto superficiale contesto contemporaneo e le cui parole, appunto, risultino soltanto per ciò che sono e dicono piuttosto che per quanto potrebbero insegnare, o quanto meno agevolare la riflessione. Le storie scritte e pubblicate diventano dunque sostanzialmente letterali e non letterarie, appunto, dotate di un semplice fine d’intrattenimento (che non è affatto secondario, per carità, ma che diviene a sua volta vuoto di senso se assurge a unico e univoco senso di un testo edito) e quasi sfuggenti da ogni accezione pienamente letteraria nonché da qualsivoglia approfondimento culturale. E’ il trionfo dei libroidi, come li ha definiti Gian Arturo Ferrari (uno che il sistema editoriale contemporaneo lo conosce fin troppo bene…) con felice e da me sovente citata intuizione, «Finti romanzi che infestano gli scaffali di librerie e biblioteche, mescolandosi alla letteratura “vera” e rendendosi di fatto indistinguibile rispetto ad essa.» ovvero testi privi di carattere letterario e dunque di valore culturale, appunto, che rivendicano un mero scopo commerciale – sovente nemmeno conseguito, il che annulla pressoché del tutto il loro senso e li rende uno spreco sostanziale di carta, inchiostro e denaro.
Insomma: quella confusione linguistica tra “letterale” e “letterario” è inopinatamente divenuta una sorta di bizzarra regola su cui si basa la produzione editoriale contemporanea, e col tempo rischia pure di trasformarsi nel sunto del suo epitaffio. Al di là di qualsiasi importante considerazione sullo stato della lettura e del mercato editoriale in Italia ovvero di come risollevarne le sorti commerciali, credo sia necessario anche un rapido e consapevole ritorno ad una scrittura nuovamente letteraria, che sappia ricuperare una preponderante valenza culturale, cognitiva, formativa ergo pure sociale e senza chiaramente mettere da parte la capacità di intrattenimento, finalmente a sua volta recuperata a scopi ben più alti e luminosi di quelli attuali. L’esercizio della scrittura deve tornare ad essere qualcosa di importanza vitale, per così dire, un atto di immensa responsabilità oltre che di natura culturale nel senso più alto del termine, appunto, ma pure politico – perché lo è da sempre e non può esimersi da esserlo, poco o tanto. Gli scrittori devono scrivere i propri libri come se non ci fosse un domani – lo hanno già rimarcato altri – o come se avessero una mannaia sopra la testa pronta a calare se quanto scritto e pubblicato risulti vuoto di valore letterario – anche perché, appunto, si è (bisogna essere) autori e scrittori, non disonesti scribacchini di futilità spacciate per letteratura!
Ecco: se ciò potrà in qualche modo essere compreso e tornare a sussistere, nella produzione editoriale, sono certo che i libri e la lettura avranno un futuro ben più roseo e solido di quanto si potrebbe temere ora. E forse, con il relativo aumento di lettori, ci si confonderà pure meno di oggi tra “letterale” e “letterario”!
P.S.: ah, visto il periodo, buone feste a tutti!